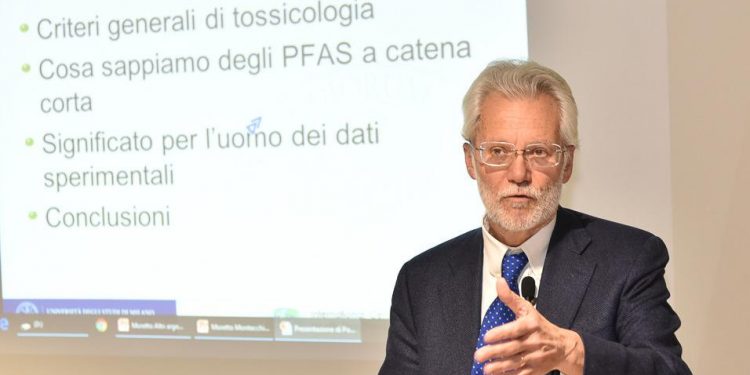Il professore Angelo Moretto è Ordinario di Medicina del Lavoro (tossicologia industriale), e da anni studia la valutazione del rischio da esposizioni a sostanze chimiche, con specifico interesse per prodotti fitosanitari e loro metaboliti, ed esposizione combinata a prodotti chimici ambientali e professionali. Bene, con molta pazienza, chiarezza e dovizia di particolari ci ha fornito una lezione private sull’annoso tema Agrofamaci e residui.
Rispetto a 20 anni fa, sono cambiati gli agrofarmaci? e in che modo?
Il progresso delle conoscenze scientifiche e delle capacità di sintesi chimica ha permesso lo sviluppo di molecole sempre più specifiche per l’agente nocivo per le colture che si vuole debellare. Questo ha fatto sì che i composti più recenti siano dotati di minore, talora molto scarsa se non nulla, tossicità per l’uomo rispetto a quelli immessi sul mercato molti anni fa e che ad essi si sono sostituiti. Certamente, sono ancora utilizzati composti introdotti nel mercato molti anni fa, ma si tratta generalmente di composti a bassa tossicità e che ancora svolgono un’azione indispensabile per la protezione delle piante e dei raccolti.
Qualche numero?
L’introduzione della legislazione comunitaria nei primi anni ’90 del secolo scorso ha favorito questo processo di eliminazione e sostituzione, visto che siamo passati da oltre 1000 a poco più di 400 composti presenti attualmente nel mercato europeo. Inoltre, è cambiato il modo di utilizzare i prodotti fitosanitari.
Cioè?
Si utilizzano con più attenzione e in minore quantità, perché si è capito meglio come gestire, anche, eventualmente, con altri mezzi, le patologie delle piante.
E gli effetti sull’ambiente? Che mi dice?
Per quanto riguarda gli effetti sull’ambiente, in particolare sulla flora e fauna “non bersaglio”, non è sempre possibile utilizzare prodotti che siano specifici per l’infestante, e quindi ci si trova nella condizione che il composto possa potenzialmente agire anche su specie “economiche”. In questi casi, la soluzione è quella di gestire le modalità d’uso in modo che l’impatto sia minimizzato. In aggiunta, la legislazione europea prevede che non siano autorizzate sostanze che permangono a lungo nell’ambiente e che si possano ritrovare oltre certi limiti nelle acque di falda.
Mi tolga una curiosità, esistono agrofarmaci naturali?
Se per naturale si intende un derivato da una pianta o da un animale, tali composti esistono. Bisogna ricordare che tutte le piante producono sostanze che combattono i parassiti e gli infestanti, e che in effetti queste sostanze rappresentano la stragrande maggioranza dei composti ad azione “pesticida” che noi ingeriamo.
Ma perché un agrofarmaco derivato da pianta o da animale dovrebbe essere meno impattante?
Non vi sono argomenti o dati scientifici per sostenere che questi composti abbiano minori effetti avversi sull’uomo o sull’ambiente: dipende dalle modalità d’uso.
Esempi?
Per esempio, l’estratto di piretro (crisantemo) contiene delle sostanze che hanno gli stessi effetti dei piretroidi di sintesi, un’azione insetticida legata all’interferenza con una certa funzione del sistema nervoso. A questo riguardo, quindi, non esiste alcuna differenza fra il composto di sintesi e quello di derivazione dal crisantemo. Anzi, è più facile che il derivato del crisantemo contenga impurità non note o non controllate che potrebbero avere effetti avversi sull’uomo. Per esempio, si segnalano più frequenti reazioni allergiche in coloro che utilizzano l’estratto di crisantemo (piretrina) rispetto a coloro che usano un piretroide di sintesi.
Veniamo un po’ alla questione cruciale: Come si studia e si controlla l’impatto con un agrofarmaco?
L’autorizzazione all’immissione in commercio e all’uso dei prodotti fitosanitari è garantita dopo che le autorità competenti, EFSA (European Food Safety Authority) e EChA (European Chemicals Agency) e i competenti ministeri (in Italia in Ministero della Salute), hanno valutato una corposa mole di studi e documenti che le industrie produttrici hanno l’obbligo di sottoporre all’esame delle autorità competenti Gli studi devono essere eseguiti in accordo con protocolli sperimentali approvati e condivisi dalla comunità scientifica al fine di garantire qualità uniforme e adeguatezza dei dati forniti.
Che requisiti di massina bisogna considerare?
Per poter essere autorizzato all’uso, un prodotto fitosanitario deve soddisfare, fra gli altri, i seguenti requisiti in seguito al suo uso corretto:
a) essere sufficientemente efficace;
b) non avere alcun effetto avverso, immediato o ritardato, sulla salute umana o animale;
c) non avere alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali.
Da questi studi si definiscono i Limiti Massimi di Residuo (LMR o MRL in inglese) che si possono trovare nelle derrate alimentari in seguito all’uso corretto dei prodotti fitosanitari, e il limite di esposizione per l’ambiente e per l’uomo. Per l’uomo, in particolare, si definiscono la Dose Giornaliera Accettabile (GDA o ADI in inglese), la Dose Acuta di Riferimento (ARfD in inglese), e per l’agricoltore la accettabile di esposizione (AOEL in inglese).
Immagino che queste sigle devono parlarsi tra loro?
Un prodotto fitosanitario è autorizzato solo se gli LMR sono compatibili con ADI e ARfD ovvero se la quantità di residuo ingerito con la dieta è inferiore a ADI e ARfD. Lo stesso, per l’agricoltore vi deve essere un’esposizione in seguito all’attività di applicazione del prodotto, inferiore all’AOEL. Se queste condizioni non sono rispettate, il composto non è autorizzato.
Bene, ma allora quando parliamo di residui di “pesticidi” di cosa parliamo?
L’utilizzo di prodotti fitosanitari può comportare la presenza di residui nei prodotti trattati o negli animali alimentati con tali prodotti. Sulla base di studi controllati si definiscono i livelli di residuo che si possono trovare nelle derrate alimentari in seguito all’uso corretto dei prodotti fitosanitari. La misura dei residui negli alimenti e il loro confronto con i Limiti Massimi di Residuo (LMR/MRL) servono per capire se il prodotto fitosanitario è stato usato correttamente, ma il loro superamento nulla ci dice sui possibili effetti sulla salute. Infatti, gli MRL sono stabiliti sulla base di considerazioni agronomiche e non di salute, e sono accettati solo se compatibili con la salute.
Cioè?
Questo vuol dire che un loro superamento non ha significato diagnostico di malattia o indicatore di rischio per la salute. Infatti, è possibile, e molto spesso accade, che le stime di assunzione con la dieta basate sugli MRL sia 10, 100 volte più basse dei limiti stabiliti per la salute (ADI e ARfD); pertanto, anche superamenti del doppio o anche di 10 volte degli MRL non pongono alcun rischio per la salute, mentre sono indice di pratiche agronomiche non rispettose delle indicazioni.
Ultima preoccupazione: riguarda il cosiddetto effetto sinergico, residui anche a bassa intensità di più molecole potrebbero causare danni.
Questo è un argomento in discussione da molti anni, EFSA e altri enti hanno proposto metodologie di valutazione dell’esposizione combinata a sostanze chimiche, non solo prodotti fitosanitari.
Partiamo da una definizione? Che si intende per effetto sinergico?
Per effetto sinergico si intende quell’effetto derivante dall’esposizione a più sostanze che risulta maggiore di quello atteso dalla semplice somma dalle caratteristiche di ogni singola sostanza. Effetti sinergici non sono attesi alle basse concentrazioni o dosi, quali quelle cui siamo esposti con i residui. L’unico effetto atteso potrebbe essere quello della somma degli effetti di sostanze ad azione simile: molte combinazioni sono state studiate da EFSA, negli Stati Uniti e in paese dell’Unione Europea e tutti questi studi hanno dato risultati rassicuranti. Non solo non ci si attende sinergia, ma neanche cumulo di effetti.